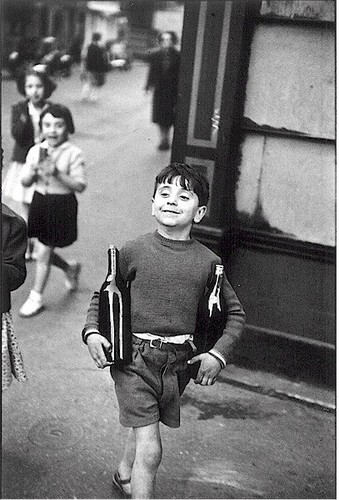Nella mente di coloro che vogliono aiutare i giovani domina l'idea di un futuro minaccioso. Ecco che allora chi esercita una responsabilità pedagogica si comporta come se avesse di fronte un pericolo: deve combattere per superarlo e per aiutare il maggior numero di persone a uscirne vittoriose. Così la nostra società diventa sempre più dura: ogni sapere deve essere "utile", ogni insegnamento deve "servire a qualcosa". Con la vittoria assoluta del neoliberismo, infatti, l'economicismo è diventato, nel mondo odierno, una specie di seconda natura. L'economia é.
sabato 28 agosto 2010
sabato 14 agosto 2010
S. Vegetti Finzi, (1986), Storia della psicoanalisi, Mondadori, Milano.
Storicizzare la psicoanalisi costi-tuisce [però], in un certo senso, un'impresa anti-psicoanalitica, perché questa forma di sapere presenta una resistenza interna alla dimensione storica. Il suo soggetto, l'inconscio, è carat-terizzato dall'atemporalità, il suo sapere si costituisce attraverso una pratica, l'intepretazione, che si vuole personale, provvisoria, sottratta alla generalizzazione, mentre il Movimento psicoanalitico, forte della sua legittimità istituzionale, si è sempre ritenuto il depositario del patrimonio teorico e metodologico acquisito. Non possiamo tuttavia concedere alla psicoanalisi il privilegio di considerarsi una teoria astorica o una prassi privata. Alla relativa staticità del suo oggetto fa riscontro infatti la storicità delle sue domande e il mutare dei suoi obbiettivi in base alle situazioni sociali e culturali nelle quali lo psicoanalizzare accade.
venerdì 13 agosto 2010
T.H. Ogden (2005), L'arte della psicoanalisi. Sognare sogni non sognati, t.i., Cortina, Milano, 2008.
Ogni madre o padre che abbia più di un figlio ha imparato (con una combinazione di stupore e delizia) che ogni nuovo bambino sembra essere solo un lontano parente dei suoi fratelli e sorelle maggiori. Un padre e una madre devono reinventare cosa è essere genitore con ciascun bambino e devono continuare a farlo in ogni fase della vita del bambino e della famiglia.
Etichette:
bambino,
famiglia,
Ogden,
psicoanalisi
giovedì 12 agosto 2010
M. Eigen (1999), Mistica e psicoanalisi, t.i., Astrolabio, Roma, 2000.
Da bambini ci veniva insegnato ad ammirare la fede di Abramo. La storia fa parte della liturgia del mattino, viene letta sette giorni alla settimana, tutte le settimane, tutti gli anni. I nostri insegnanti non sembravano particolarmente sensibili alla sua sgradevolissima consistenza. Ce la imprimevano nell'anima, in una sorta di circoncisione psico-spirituale. Probabilmente provavano un piacere sadico per il nostro orrore latente: Abramo è nostro padre, Dio ci salva dal nostro folle padre. Ma chi ci salverà dal nostro folle Dio?
Etichette:
Abramo,
ebraismo,
Eigen,
psicoanalisi
lunedì 9 agosto 2010
W.R. Bion (1965) , Trasformazioni. Il passaggio dall'apprendimento alla crescita, t.i., Astrolabio, Roma, 1973.
E' impossibile conoscere la realtà per la stessa ragione per cui è impossibile cantare le patate; esse possono essere coltivate, estirpate o mangiate, ma non cantate. La realtà deve essere 'essuta': dovrebbe esserci un verbo transitivo 'essere' da usare al passivo espressamente con il termine 'realtà'.
domenica 8 agosto 2010
G. Guidorizzi [a cura di] (2009), Il mito greco, Mondadori, Milano.
Visto che, allora, sulla Terra nessuno più moriva, gli déi intervennero e Ares, lo Sterminatore, liberò la Morte. Così Sisifo dovette scendere nell'Ade. Non aveva però esaurito le sue astuzie: prima di morire aveva raccomandato a sua moglie Merope di non tributargli onori funebri e nell'oltretomba si mostrò tanto afflitto di quest'offesa, che riuscì a impietosire gli déi infernali, i quali gli consentirono di tornare sulla Terra per punire la sposa e compiere i funerali. Il patto era che subito dopo ridiscendesse tra i morti, ma Sisifo si guardò bene dal rispettarlo. Dovette, comunque morire, alla fine, e nell'Ade compare tra i grandi peccatori. Il suo inutile supplemento di vita è castigato con una pena simbolica: com'era stata vana la fatica a ingannare la Morte, così è vano il suo infinito sforzo di spingere fino in cima a un monte un macigno, perché questo, inesorabilmente, rotola indietro.
Etichette:
Ade,
Guidorizzi,
Mito greco,
Morte,
Sisifo
venerdì 6 agosto 2010
H. Fainberg (2005), Ascoltando tre generazioni. Legami narcisistici e identificazioni alienanti, t.i., Franco Angeli, Milano, 2006.
mercoledì 4 agosto 2010
S. Argentieri (2010), A qualcuno piace uguale, Einaudi, Torino.
... mi riferisco all'eccessiva attenzione e importanza deputata dagli uomini alla loro virilità e al bisogno di esibirla e vederla confermata; sul piano esplicito e concreto delle performance sessuali e delle conquiste femminili, delle misure e dei numeri, ma anche - nei casi estremi e patologici - con la sopraffazione e la violenza contro le donne e contro i maschi più deboli. Il fallo non è un mezzo per incontrare l'altro ma un'arma impropria; la partner non è un'occasione di piacere condiviso, ma un test della propria prestazione. Alla svalutazione delle donne corrisponde la parallela idealizzazione degli uomini, la ricerca della frequentazione maschile di gruppo, con intimità corporee da caserma o da stadio tutt'altro che limpide, colorate da vistose quote sadiche omosessuali al tempo stesso agite e negate.
Direi che lo stile fascista è il modello fallico per eccellenza, tanto prepotente quanto interiormente fragile. D'altronde, sappiamo bene quanto le fantasie di onnipotenza siano l'altra faccia delle angosce di impotenza. La fallicità si manifesta infatti anche sul piano simbolico della competizione, dell'esibizionismo della forza muscolare e del potere, del piacere della sfida; tanto prepotente quanto continuamente esposto al rischio del fallimento.
martedì 3 agosto 2010
lunedì 2 agosto 2010
R. Dadoun (1992), Sigmund Freud, t.i., Spirali, Milano, 1997.
Da Avvertenze preliminari
... ci sembra, e numerose manifestazioni potrebbero attestarlo, che il pensiero freudiano costituisca un pezzo strategico di primaria importanza nella conflittualità propriamente antropologica, concernente cioè l'essere, la realtà essenziale e la sopravvivenza dell'uomo, che caratterizza ormai un mondo segnato da una simmetria terribile e mortale. Sia la tirannia e l'influenza dei sistemi, delle organizzazioni e delle strutture di massa, con i loro capi dal carisma nebuloso e tremendo, sia le stupefacenti capacità d'illusione dei media, sia gli strumenti di distruzione totale in permanente disponibilità e in costante incremento esigono, a nostro avviso, che si dia o si ridia alla soggettività umana, al Soggetto, ossia all'individuo lucido, non ignaro delle sue strutture interne, della sua "terribile simmetria", un potere ineguagliato e propriamente elementare di resistenza, di sfida e di iniziativa. Per parafrasare una celebre formula di Freud, potremmo dire: Dove la Massa domina, ottenebra, schiaccia, il Soggetto deve avvenire!
Chi meglio di Freud ha designato le vie e i mezzi di quest'autonomia individuale, ha isolato e descritto le energie prime per una lucidità e una libertà fondate sull'intima e necessaria conoscenza dell'inconscio psichico e dell'inconscio politico? Ma, se in lui si trovano i principi e gli strumenti di un pensiero chiaro e distinto e alcune regole di tecnica psicologica, "elastiche", precisa, Freud non propone né regole di condotta e d'azione né leggi di moralità pratica; in nessun momento Freud si presenta come una "guida di vita".
Chi meglio di Freud ha designato le vie e i mezzi di quest'autonomia individuale, ha isolato e descritto le energie prime per una lucidità e una libertà fondate sull'intima e necessaria conoscenza dell'inconscio psichico e dell'inconscio politico? Ma, se in lui si trovano i principi e gli strumenti di un pensiero chiaro e distinto e alcune regole di tecnica psicologica, "elastiche", precisa, Freud non propone né regole di condotta e d'azione né leggi di moralità pratica; in nessun momento Freud si presenta come una "guida di vita".
domenica 1 agosto 2010
M. Mancia (2010), Narcisismo. Il presente deformato dallo specchio, Boringhieri, Torino.
 Quello che non appare chiaro nel pensiero di Freud è quale tipo di dolore mentale produca nell'uomo il dover uscire dal suo universo narcisistico e dover riconoscere la dipendenza dall'altro e il bisogno dell'altro, e quale collocazione possa avere questo dolore nell'ambito della relazione analitica.
Quello che non appare chiaro nel pensiero di Freud è quale tipo di dolore mentale produca nell'uomo il dover uscire dal suo universo narcisistico e dover riconoscere la dipendenza dall'altro e il bisogno dell'altro, e quale collocazione possa avere questo dolore nell'ambito della relazione analitica.
Iscriviti a:
Post (Atom)