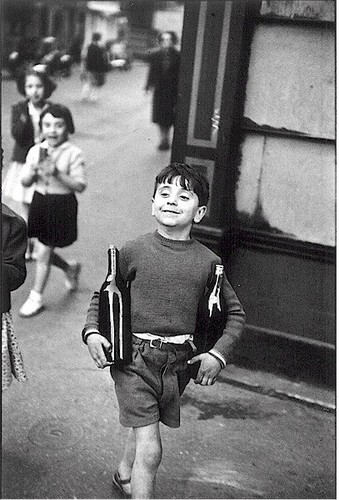In Albania c’è una montagna piena di sangue. Lo assorbe dappertutto. Una volta l’anno, in un immenso anfiteatro di roccia sotto la sua cima, migliaia di montoni, capre, agnelli, pecore e galli vengono sacrificati davanti a eserciti di pellegrini musulmani, affiancati da cattolici, cristiani ortodossi, agnostici, superstiziosi e atei affascinati dall’invisibile.
È l’ultimo macello d’Europa. Una densa nube rossastra ne nasconde la cima per giorni. Ha un nome terribile, che nessuno pronuncia e che in albanese vuol dire “paura”. Loro la chiamano semplicemente “la Montagna” per rispetto e per depistare gli intrusi.
In cima, accanto a una tomba, c’è una grande vasca di pietra dove cola il liquido fumante. Il sacrificio è per lui, Abbas Ali (il genero di Maometto), secondo la tradizione scampato miracolosamente al massacro di Karbala, in Mesopotamia, nel 680° secolo dopo Cristo è fuggito fin qui. La tomba è sua ed è attorno ad essa che gli albanesi – in maggioranza bektashi, cioè di origine sciita – vengono a sgozzare animali e ballare notti intere attorno al fuoco, stringendosi ai maestri spirituali. Guardano loro come venerabili dopo mezzo secolo di ateismo di Stato. Portano vestiti verdi, turbanti, barbe lunghe, e tutti hanno sguardi pieni di calma serafica.
Baba Edmundi, appena tornato dall’Anatolia, dona a centinaia di pellegrini il proprio respiro. Aspira, nel suo corpo, tutte le sciagure che gli vengono raccontate. Un anziano lo abbraccia dopo avergli raccontato un sogno e lo bacia sul petto. Inspira amori infelici, tristezza inguaribili, dolori lombari, alcolismo dei parenti, debiti non pagati.
I bektashi sono in bilico tra sciismo e sunnismo, attraverso la poetica e i mistici dell’Islam senza confini. Sono considerati più vicini al Cristianesimo che all’Islam. Invece della Mecca pellegrinano nella loro anima. I loro maestri sono più importanti del Corano e della Legge. Dove loro dormono sarà santificato dal loro sonno. I maestri hanno raggiunto dentro sé l’Uomo Perfetto che, a sentire i bektashi, abita dentro ognuno di noi. I maestri sono l’esempio.
I maestri respingono le passioni e praticano il celibato, l’ascesi e un severo noviziato, come i monaci cristiani. Non sono presenti donne blindate con veli o recluse in spazi ristretti. Sulla sacra montagna ci sono folle di ragazze in jeans, con braccia scoperte o in minigonna. Il velo fu vietato già nel 1937 a segnare la rottura con l’Albania e con le gerarchie conservatrici della Jugoslavia e del Kosovo.
Abbas Alì ogni anno ad agosto, scende dal cielo per cinque giorni. Si vedono i macellai-sacerdoti, gli agnelli spaventati, gli schizzi di plasma, il nauseabondo olezzo di carne, i meandri degli intestini trascinati dai cani, la puzza di bruciato, i mucchi di pelli, teste di mucche sgozzate. Migliaia di falò proiettano sui colli le ombre dei danzatori, cerchi di vecchie donne attorno ai roghi, ragazzi che girano gli spiedini o bevono la birra. Dopo cinque giorni il santo, abbuffato e sazio, torna in cielo. Gli zingari raccolgono le interiora rimaste nei canali di scolo. Le pelli sono state portate via e ora mancano i lupi, che fiutano da giorni il sangue lontano.